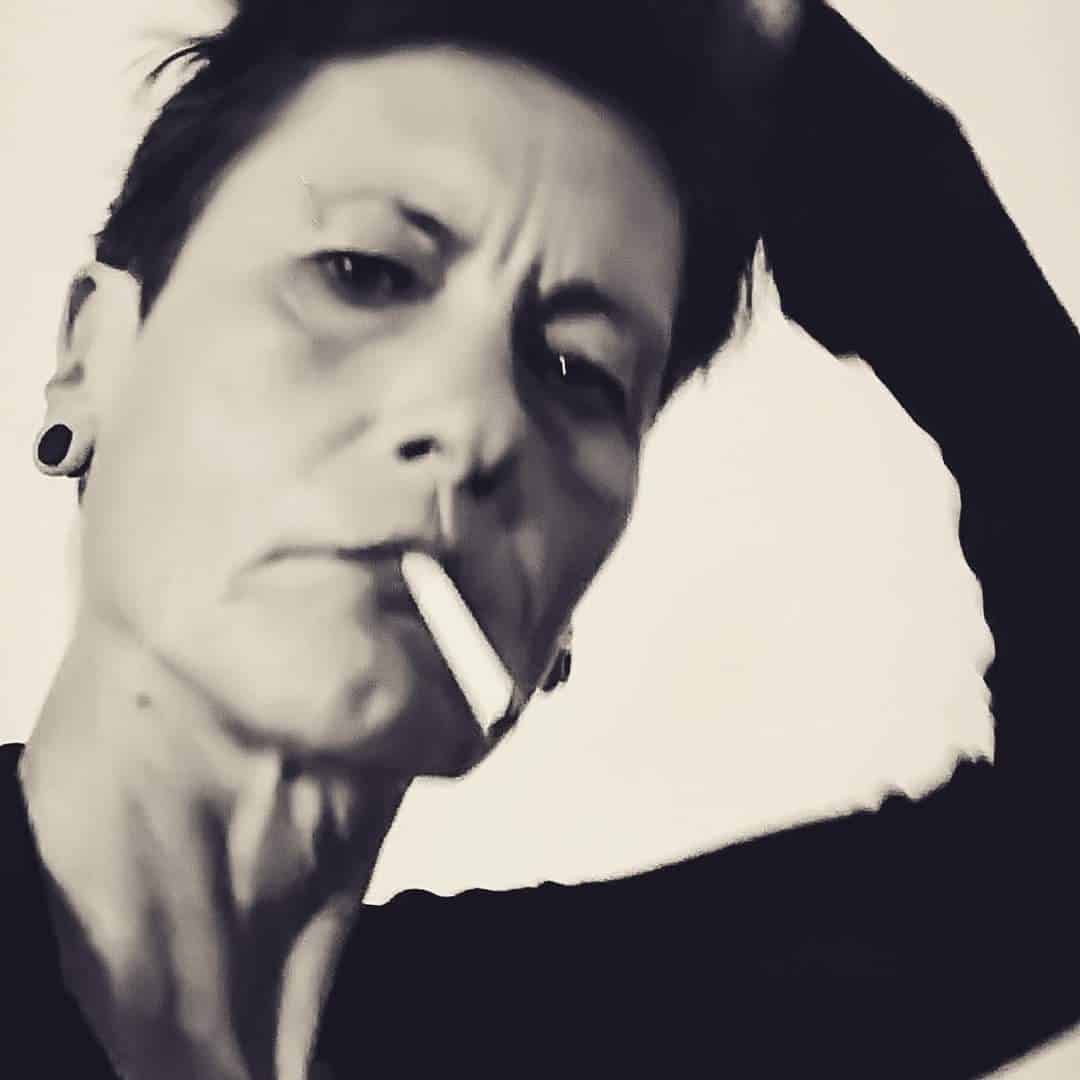
La poesia di Stefania Licciardello è un evento. Così l’ho sempre vissuta, attendendo con impazienza i suoi versi da leggere in anteprima. Leggerli è stato per me una maniera di restare ancorata al pensiero in una lunga fase di inattività e le sarò sempre grata per questo. Il Libro dei Bisogni è la terza raccolta di versi di Stefania. È stata scritta nella cornice storica della pandemia di Covid 19 e ne porta il segno. Le tracce di questo periodo sono sparse nei componimenti e consistono in solitudini più dense, copiose rimembranze, silenzi e stanze vuote. Si fa inoltre più fitta la compagnia del paredro Gina (“la cana”). Le lunghe file dalle autostrade si spostano al supermercato, la nostalgia del mare è più intensa che mai e un erpice lontano compare a ricordare il lavoro dei campi interrotto dal confinamento; nella chiusa della raccolta un bar diventa quasi un luogo di trasfigurazione: “entro nel bar e non sono ferita / tutta questa luce / il mare mi cola dagli occhi”.
Anche qui, come negli altri componimenti di Stefania, la pandemia è in ogni caso un “pretesto”. A suo tempo avevo parlato della poesia dell’autrice quale sbocco della “voce” del poeta; questi resta sul trampolino di lancio delle sue parole, ne è l’origine ma non il senso. Lo stesso accade per i temi che danno avvio alla raccolta. Il Libro dei Bisogni ci conduce nella località precipua nella quale il soggetto della poesia – sia esso rappresentato da persone, cose, paesaggi, pensieri astratti, emozioni – acquisisce indistintamente figuralità perdendo la propria connotazione originaria. Non vi sono in questi versi “ponti” tra l’immagine e il concetto come vorrebbe la metafora. Nella poesia di Stefania non esistono metafore bensì figure. È infatti sufficiente addentrarsi tra le prime pagine della raccolta per comprendere che in questione non è la rima, il concetto o l’emozione del poeta bensì alcunché di numinoso. I versi sono personificazioni autonome, irriducibili di stati, pensieri, luoghi, emozioni esattamente come gli antichi dèi della mitologia. Se le deità assumono su di loro ogni aspetto dell’esistente facendosene corpo vivente, esplosivo di polarità, le immagini dei componimenti di Stefania ne sono il correlato simbolico suppletivo. I versi assumono i contorni delle antiche figure metafisiche sopite o estinte: “I volti in rovina sono belli che prima c’era un miraggio”.
La rovina in questo senso rimanda a quel divenire altro, il perdere in intensità e bellezza che fa capo al ciclo organico di giovinezza, maturità e vecchiaia. Questo ciclo tuttavia viene dissolto dalla poesia; nei versi fa irruzione la compiutezza della forma e la coesistenza di stati; ciò che appare in rovina è dunque simultaneamente un miraggio: La poesia, volto e miraggio, ha annientato il tempo ed è, perciò stesso, località dell’eterno. Arte e religione sono così complementari (rimando qui al bellissimo libretto di Jean-Luc Nancy, Le Muse) forse persino sovrapponibili, a patto di leggere la potenza figurale del racconto poetico che ci fa avvicinare ai grandi misteri, ce li fa incontrare per stato di grazia, senza preghiera: “Frenesia è la scrittura / è pace senza guerra / accade per grazia”
La stessa grazia concede anche l’incontro con la morte, intesa come una compagna che si può accogliere o respingere ma che si presenta delicatamente, con amore: “La morte è nell’aria/come sempre / non dobbiamo morire se non ce la sentiamo”. Nonostante sia lei ad aprire e chiudere il libro non v’è traccia di angoscia in questi versi. La sua figura muta consiste piuttosto di una prossimità che prelude ad un varco, ad una vicinanza: “è talmente bello vivere /che per forza / è bello morire / ma ne so così poco”. La relazione della morte con la vita, il loro misterioso avvicendamento (come pure quello “magico” tra vita e poesia) evoca il mistero della prossimità degli opposti e ci conferma che la poesia di Stefania si colloca sul crinale del mito. In esso le figure degli dèi contengono ogni opposizione incorporandola e agiscono ogni contraddizione vivendola poiché il mito, come la poesia, è totalità dispiegata in forma. Nella poesia vige il segno del medesimo esistere che convoca ogni opposizione presentandola come unico viluppo: “la cosa più violenta è esistere”, leggiamo altrove nella raccolta; anche il verso quale portavoce della totalità dell’esistente afferma il tutto come forma. È la vertigine del senso, è il rogo delle metafore, il grumo ostinato dell’esistere come figurazione. Questa foggia della poesia tuttavia non è possesso, resto bensì dissipazione del senso affermato dalla propria negazione. Stefania lo racconta in questi versi: “Tutto quello che abbiamo non è solo quello che resta/nella carestia l’estate brilla”.
L’immagine è talmente rilevante da essere ricorsiva; altrove si legge: “d’estate brilla la carestia”. Il significato inesauribile di questo verso e del suo gemello- a mio avviso sigilli di tutta la raccolta- rimanda a una costellazione semantica disseminata ma puntuale. Il sole accecante dell’estate siciliana, le stoppie bruciate dal sole di agosto, la fucina di Efesto che splende nella cavità ctonia di Etna, la Kore rapita da Ade nella rigogliosa Pergusa sono tutte figurazioni del bagliore di carestia sul piano mitico e dunque anche simbolico e naturale. D’estate il raccolto dei frutti è già avvenuto e nondimeno perdura nell’oro paglierino delle stoppie il segno aureo dell’abbondanza che fu. In estate (e al massimo livello nell’estate siciliana alla quale fa riferimento Stefania) la luce accecante è ad un passo dall’annientare ogni immagine; è quella luce tuttavia a traslare il paesaggio al livello assolato e assoluto della figurazione: Il sole dispiegato brucia e acceca, non possiamo commentare una figura così potente, ben al di là di ogni metafora. Sul suo piano, spesso corrispondente a quello della realtà, la poesia è spietatamente vera. Per tutto ciò che significa, che esibisce senza farsene metafora bensì “corporeamente”, la luce accecante della carestia è la poesia.
Abbiamo potuto finalmente saltare i ponti che le metafore hanno sempre istruito per concederci quella gradualità del numinoso che non “brucia”- e che Platone rappresentava ne “Il mito della caverna”. Ciò è possibile poiché non ci si dà in pasto alla potenza delle immagini conservando la propria identità, viceversa ci si lascia miticamente invadere da esse fino a sparire. Soltanto le figure della poesia possono ardere, farsi annientare e comparire allo stesso tempo, noi dobbiamo farci ombre e gioiosamente sparire. Una versione umbratile del discente, contro-platonicamente appannaggio del mito, è adesso possibile. Uscire dalla caverna senza mediazioni idealistiche è necessario, pena la morte delle immagini- e con esse della poesia- per la nostra prosaica resistenza all’annientamento volontario: “Ti seguo / e sono sparsa ovunque / non posso vedere la tua parte di verità / solo brandelli / la notte fanno baldoria”. In questi versi v’è la descrizione letterale del lettore integrale; la lettura è in questa cornice un’esperienza talmente intensa da generare un gioioso, dionisiaco frastuono in un lettore preparato al salto nella poesia: “Le parole senza capestri fanno rumore / Un brusio felice infantile gira intorno”. Leggendo questi versi possiamo finalmente compiere quel viaggio di trasmutazione che la poetessa per prima ha fatto, consegnandolo alla scrittura e a noi. Al termine del viaggio non ci siamo più noi, non per questo ci siamo fatti poveri di senso, anzi il contrario: L’estate della carestia dopo averci stordito, accecato e trasfigurato ci riporta indietro. Siamo a casa, siamo vivi e vegeti. Ci è passato sopra il bagliore della carestia, ci ha trasformati e risputati al di là della sua landa. Così noi rinasciamo alle nostre antiche abitudini ma avvezzi a sempre più nuovi, sorgivi bisogni.
Anche qui, come negli altri componimenti di Stefania, la pandemia è in ogni caso un “pretesto”. A suo tempo avevo parlato della poesia dell’autrice quale sbocco della “voce” del poeta; questi resta sul trampolino di lancio delle sue parole, ne è l’origine ma non il senso. Lo stesso accade per i temi che danno avvio alla raccolta. Il Libro dei Bisogni ci conduce nella località precipua nella quale il soggetto della poesia – sia esso rappresentato da persone, cose, paesaggi, pensieri astratti, emozioni – acquisisce indistintamente figuralità perdendo la propria connotazione originaria. Non vi sono in questi versi “ponti” tra l’immagine e il concetto come vorrebbe la metafora. Nella poesia di Stefania non esistono metafore bensì figure. È infatti sufficiente addentrarsi tra le prime pagine della raccolta per comprendere che in questione non è la rima, il concetto o l’emozione del poeta bensì alcunché di numinoso. I versi sono personificazioni autonome, irriducibili di stati, pensieri, luoghi, emozioni esattamente come gli antichi dèi della mitologia. Se le deità assumono su di loro ogni aspetto dell’esistente facendosene corpo vivente, esplosivo di polarità, le immagini dei componimenti di Stefania ne sono il correlato simbolico suppletivo. I versi assumono i contorni delle antiche figure metafisiche sopite o estinte: “I volti in rovina sono belli che prima c’era un miraggio”.
La rovina in questo senso rimanda a quel divenire altro, il perdere in intensità e bellezza che fa capo al ciclo organico di giovinezza, maturità e vecchiaia. Questo ciclo tuttavia viene dissolto dalla poesia; nei versi fa irruzione la compiutezza della forma e la coesistenza di stati; ciò che appare in rovina è dunque simultaneamente un miraggio: La poesia, volto e miraggio, ha annientato il tempo ed è, perciò stesso, località dell’eterno. Arte e religione sono così complementari (rimando qui al bellissimo libretto di Jean-Luc Nancy, Le Muse) forse persino sovrapponibili, a patto di leggere la potenza figurale del racconto poetico che ci fa avvicinare ai grandi misteri, ce li fa incontrare per stato di grazia, senza preghiera: “Frenesia è la scrittura / è pace senza guerra / accade per grazia”
La stessa grazia concede anche l’incontro con la morte, intesa come una compagna che si può accogliere o respingere ma che si presenta delicatamente, con amore: “La morte è nell’aria/come sempre / non dobbiamo morire se non ce la sentiamo”. Nonostante sia lei ad aprire e chiudere il libro non v’è traccia di angoscia in questi versi. La sua figura muta consiste piuttosto di una prossimità che prelude ad un varco, ad una vicinanza: “è talmente bello vivere /che per forza / è bello morire / ma ne so così poco”. La relazione della morte con la vita, il loro misterioso avvicendamento (come pure quello “magico” tra vita e poesia) evoca il mistero della prossimità degli opposti e ci conferma che la poesia di Stefania si colloca sul crinale del mito. In esso le figure degli dèi contengono ogni opposizione incorporandola e agiscono ogni contraddizione vivendola poiché il mito, come la poesia, è totalità dispiegata in forma. Nella poesia vige il segno del medesimo esistere che convoca ogni opposizione presentandola come unico viluppo: “la cosa più violenta è esistere”, leggiamo altrove nella raccolta; anche il verso quale portavoce della totalità dell’esistente afferma il tutto come forma. È la vertigine del senso, è il rogo delle metafore, il grumo ostinato dell’esistere come figurazione. Questa foggia della poesia tuttavia non è possesso, resto bensì dissipazione del senso affermato dalla propria negazione. Stefania lo racconta in questi versi: “Tutto quello che abbiamo non è solo quello che resta/nella carestia l’estate brilla”.
L’immagine è talmente rilevante da essere ricorsiva; altrove si legge: “d’estate brilla la carestia”. Il significato inesauribile di questo verso e del suo gemello- a mio avviso sigilli di tutta la raccolta- rimanda a una costellazione semantica disseminata ma puntuale. Il sole accecante dell’estate siciliana, le stoppie bruciate dal sole di agosto, la fucina di Efesto che splende nella cavità ctonia di Etna, la Kore rapita da Ade nella rigogliosa Pergusa sono tutte figurazioni del bagliore di carestia sul piano mitico e dunque anche simbolico e naturale. D’estate il raccolto dei frutti è già avvenuto e nondimeno perdura nell’oro paglierino delle stoppie il segno aureo dell’abbondanza che fu. In estate (e al massimo livello nell’estate siciliana alla quale fa riferimento Stefania) la luce accecante è ad un passo dall’annientare ogni immagine; è quella luce tuttavia a traslare il paesaggio al livello assolato e assoluto della figurazione: Il sole dispiegato brucia e acceca, non possiamo commentare una figura così potente, ben al di là di ogni metafora. Sul suo piano, spesso corrispondente a quello della realtà, la poesia è spietatamente vera. Per tutto ciò che significa, che esibisce senza farsene metafora bensì “corporeamente”, la luce accecante della carestia è la poesia.
Abbiamo potuto finalmente saltare i ponti che le metafore hanno sempre istruito per concederci quella gradualità del numinoso che non “brucia”- e che Platone rappresentava ne “Il mito della caverna”. Ciò è possibile poiché non ci si dà in pasto alla potenza delle immagini conservando la propria identità, viceversa ci si lascia miticamente invadere da esse fino a sparire. Soltanto le figure della poesia possono ardere, farsi annientare e comparire allo stesso tempo, noi dobbiamo farci ombre e gioiosamente sparire. Una versione umbratile del discente, contro-platonicamente appannaggio del mito, è adesso possibile. Uscire dalla caverna senza mediazioni idealistiche è necessario, pena la morte delle immagini- e con esse della poesia- per la nostra prosaica resistenza all’annientamento volontario: “Ti seguo / e sono sparsa ovunque / non posso vedere la tua parte di verità / solo brandelli / la notte fanno baldoria”. In questi versi v’è la descrizione letterale del lettore integrale; la lettura è in questa cornice un’esperienza talmente intensa da generare un gioioso, dionisiaco frastuono in un lettore preparato al salto nella poesia: “Le parole senza capestri fanno rumore / Un brusio felice infantile gira intorno”. Leggendo questi versi possiamo finalmente compiere quel viaggio di trasmutazione che la poetessa per prima ha fatto, consegnandolo alla scrittura e a noi. Al termine del viaggio non ci siamo più noi, non per questo ci siamo fatti poveri di senso, anzi il contrario: L’estate della carestia dopo averci stordito, accecato e trasfigurato ci riporta indietro. Siamo a casa, siamo vivi e vegeti. Ci è passato sopra il bagliore della carestia, ci ha trasformati e risputati al di là della sua landa. Così noi rinasciamo alle nostre antiche abitudini ma avvezzi a sempre più nuovi, sorgivi bisogni.
Chiara Tinnirello
L’edizione cartacea del libro può essere acquistata scrivendo a Neon Edizioni.

Lascia un commento